
Sono venticinque i Comuni italiani – dalle Alpi al Mediterraneo – che hanno ufficialmente manifestato il proprio interesse a diventare Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2028. L’elenco, reso noto dal Ministero della Cultura, testimonia la vitalità di territori eterogenei che vedono nella cultura un’opportunità concreta di crescita, rigenerazione urbana e coesione sociale.
Le candidature provengono da tutto il Paese e rappresentano un mosaico affascinante di storie, vocazioni e identità: dalle grandi città come Catania, Ancona e Forlì ai borghi di profonda tradizione come Colle di Val d’Elsa, Galatina e Tarquinia; dai contesti urbani della pianura padana, come Rozzano e Moncalieri, alle aree interne del Sud, con Sessa Aurunca, Melfi o la “Città Caudina”, un’unione di comuni campani.
Tra le regioni più attive spicca la Campania, con ben cinque candidature singole (Bacoli, Benevento, Mirabella Eclano, Sala Consilina, Sessa Aurunca) e una candidatura collettiva. Un segnale forte che arriva da un territorio ricchissimo di stratificazioni culturali, ma spesso alla ricerca di nuove visioni di sviluppo sostenibile.
Nel Centro Italia, il Lazio presenta tre candidature: Anagni, Pomezia e Tarquinia, a testimonianza di una regione che intreccia storia romana, medioevo e contemporaneità. La Toscana, come sempre dinamica, si presenta con Massa, Fiesole e Colle di Val d’Elsa. La Puglia rilancia la sua vocazione culturale con Vieste, Galatina e Gravina in Puglia, mentre anche regioni meno frequentemente protagoniste, come la Basilicata (con Melfi), la Liguria (con Sarzana) e il Veneto (con Pieve di Soligo e Valeggio sul Mincio), entrano con convinzione nella partita.
Tutte le città candidate dovranno ora predisporre, entro il 25 settembre 2025, un dossier completo che illustri il progetto culturale, la visione strategica per lo sviluppo territoriale, le modalità di coinvolgimento della cittadinanza e degli attori locali, il piano di sostenibilità economica e gli obiettivi attesi. Il percorso è strutturato e rigoroso, ma anche stimolante: mette alla prova la capacità progettuale e la visione futura dei territori.
La Capitale Italiana della Cultura, istituita nel 2014, si è affermata negli anni come un volano per la trasformazione delle città. Ne sono testimonianza esperienze già concluse, come quelle di Matera (2019), Parma (2020-21), Procida (2022), Bergamo e Brescia (2023), e quelle in corso o in programma: Pesaro nel 2024, Agrigento nel 2025, L’Aquila nel 2026 e Pordenone nel 2027.
Ogni edizione ha lasciato in eredità infrastrutture, reti culturali, nuovi modi di fare progettazione dal basso. Il titolo non è solo un riconoscimento simbolico, ma uno strumento di politica culturale che promuove un modello di sviluppo fondato sulla creatività, sull’inclusione e sulla capacità di raccontare il territorio attraverso le sue storie, i suoi luoghi e le sue comunità.
Entro marzo 2026, una giuria di esperti selezionerà la città vincitrice. Ma il processo stesso – la costruzione dei dossier, il confronto tra territori, l’attivazione delle energie locali – è già di per sé un patrimonio condiviso, un’opera d’arte collettiva fatta di visioni e desideri.
L’Italia si conferma così una nazione dove la cultura non è solo memoria, ma forza viva e generativa. In attesa di conoscere chi raccoglierà il testimone da Pordenone nel 2028, è chiaro fin d’ora che la sfida è aperta, e il futuro parla il linguaggio della bellezza, della partecipazione e della progettualità culturale.
08/07/2025




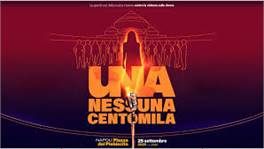


Inserisci un commento